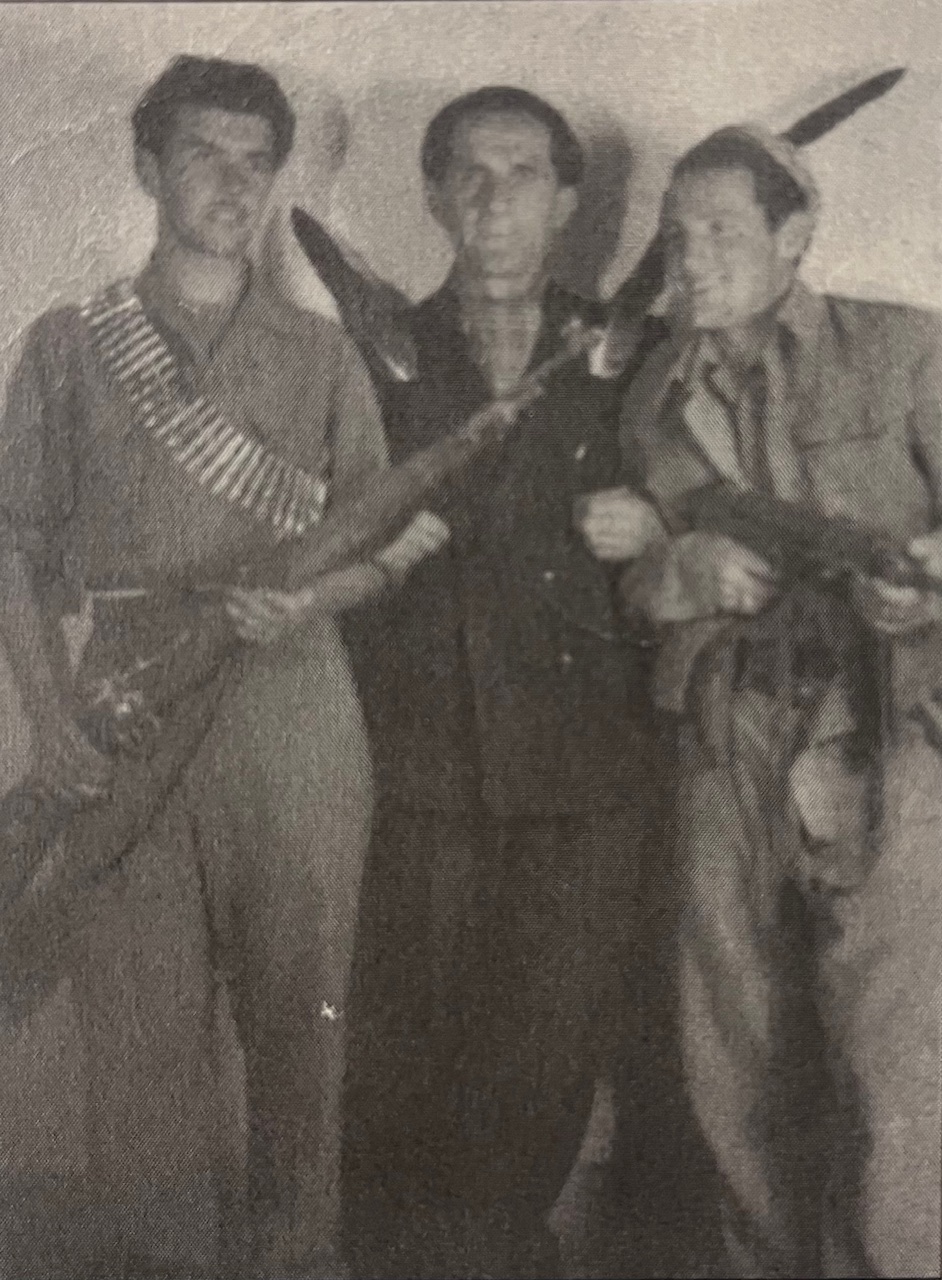Lo scontro di San Pietro in Cerro
Il 26 aprile la 141ª Brigata “A. Castagnetti” comandata da Franco Rovelli, supportata da reparti brasiliani ed americani vorrebbe tentare l’affondo per liberare tutto il territorio fino al Po, ma l’avanzata deve subire una battuta d’arresto a causa della presenza nei comuni rivieraschi dei tedeschi asserragliati in assetto di guerra e decisi a difendere gli attraversamenti che consentono loro di superare il fiume in piena e continuare la ritirata verso Nord. Nei giorni precedenti i presidi fascisti della Gnr sono stati cacciati da San Nazzaro, Caorso, Roncaglia, Chiavenna, Muradolo e Polignano, ma movimenti di corazzati tedeschi sono segnalati ancora a Caorso e un reparto bene armato e dotato di carri armati e cannoni staziona a Cortemaggiore. L’obiettivo delle forze partigiane – con la 62ª Brigata della Divisione Valdarda, attestata dalla sera precedente sulla via Emilia nei pressi di Alseno, e in partenza da Fiorenzuola con la 38ª – è infatti quello di attuare un piano di occupazione dei centri di Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, Caorso, San Pietro in Cerro e Villanova d’Arda con il compito di interrompere il traffico sulle strade che da Est portano a Piacenza.
La linea difensiva tedesca, costituita da circa 700 uomini dotati di cinque carri armati al comando del capitano Eduard Bittman, si allunga da Soarza fino a Mortizza.
Cortemaggiore, abbandonata dal presidio della Brigata nera il 22 aprile, è stata rioccupata quella stessa mattina: i tedeschi controllano tutte le vie di accesso al paese e prelevano 200 ostaggi per dissuadere i partigiani da ogni intenzione di attacco, rinchiudendoli nel cinema del paese. La Divisione tedesca, martellata da intensi bombardamenti alleati che durano diverse ore, riesce a fatica solo prima di sera a superare il Po, al prezzo di moltissime vittime. Rievoca quella che allora era una bambina di undici anni: “Io ricordo sempre tutti quei cadaveri trasportati dalla corrente del grande fiume, che non avevano un nome, senza una preghiera, senza una lacrima che li accompagnasse” (testimonianza di Maria Teresa Chiesa, E, Mariani, 2006). Le stesse scene si ripetono in tutti gli attraversamenti, come al traghetto con trazione a remi del Tinazzo di Monticelli, che ha una portata di 10 tonnellate, come a San Nazzaro e a Mezzano di Castelvetro.
Alle 18:00, quando il grosso di mezzi e uomini ha superato il fiume, gli ostaggi vengono rilasciati e incomincia il violento scontro con le forze partigiane e alleate. La battaglia notturna vede fronteggiarsi un reparto tedesco schierato a San Pietro in Cerro e nei pressi di Monticelli, Villanova e Caorso e le forze alleate alla periferia di Cortemaggiore, a cui si affiancano la 38ª e la 62ª Brigata della Valdarda partite congiuntamente da Fiorenzuola lungo la statale per Cremona. “Lo scontro fu immediato, rabbioso, gigante forse l’ultimo grande sussulto in cui si spegnevano sulla nostra terra venti mesi di duri combattimenti. Sulla sponda del Po, tra San Nazzaro e il ponte di Cremona, le due Brigate infliggevano nuove gravi perdite al nemico in fuga disordinata sulle acque tumultuose del fiume e rastrellavano numerosi prigionieri e abbondante materiale bellico” (G. Prati, 1994).
L’ultima sparatoria avviene nei pressi di San Nazzaro, dove un gruppo di tedeschi si è rifugiato per proteggere la ritirata di alcuni camerati; la maggior parte dei nemici rimasti sulla riva emiliana si arrende. Nelle prime ore del 27 aprile la 62ª e le forze alleate occupano Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Castelvetro, Caorso e Monticelli d’Ongina, con il fondamentale aiuto delle Sap – le Squadre d’azione patriottica – da sempre il cuore della Resistenza di pianura. Sono finalmente liberi i paesi rivieraschi dove fin dal primo dopoguerra il fascismo aveva imposto il proprio violento dominio e dove la Rsi e i tedeschi avevano mantenuto il controllo solo con la feroce repressione degli esponenti dei Cln e della Resistenza, attraverso i rastrellamenti della Polizia di sicurezza tedesca di Remo del Sole, l’incombente presenza delle SS di Michele Lombardo a san Giuliano di Castelvetro, le incursioni delle Brigate nere, tra cui quella di Cremona, del fanatico filotedesco Roberto Farinacci. Le numerose uccisioni di collaborazionisti nei giorni immediatamente seguenti alla Liberazione esprimono l’asprezza della guerra civile di queste zone e il doloroso effetto sui civili.
Dopo le battaglie, per tanti, invece, è arrivato il tempo della festa. Partigiani e americani provvedono a rastrellare i tedeschi e tutto l’equipaggiamento di armi e mezzi abbandonati nelle campagne: cavalli, armi, mezzi. “Nei giorni seguenti approntammo un’asta per la loro vendita ai contadini. – ricorda Cesare Casaroli della 62ª- Fu un giorno memorabile, sia dal punto di vista storico che da quello umano. Tutta la gente riversata nelle strade ad applaudire le avanguardie dell’esercito alleato che avanzava in forze preponderanti verso nord; non era inconsueto assistere a momenti di generale euforia, attorno a qualche automezzo carico di truppa intenta a distribuire generi di conforto e sigarette alla popolazione che fraternizzava entusiasta”. E un altro partigiano ricorda: “Non so descrivere le emozioni di quei momenti, ero euforico ma confuso, felice ma svuotato di energie, con una gran voglia di rivedere mia mamma ma con il timore che lei mi rimproverasse. La mamma Milia mi ha abbracciato forte, è stata in silenzio per qualche secondo, poi con una mano ha fatto il gesto di picchiarmi e mi ha detto nel dialetto parmigiano della Bassa: t’è mia pö da direm dal buzii, t’èva dit ca t’andèva a scondat dal zio Rico a Funtanlè e invece at s’è andè in montagna senza dirmal!” (Guai a te se mi dici ancora bugie! Mi avevi detto che andavi a nasconderti a Fontanellato dallo zio Enrico e invece sei andato in montagna senza dirmelo!)”
Nel periodo resistenziale, nei comuni di Monticelli, Caorso e Castelvetro hanno perso la vita 37 uomini e donne della Resistenza oltre a diverse centinaia di civili, 19 deportati politici e 3 ebrei, mentre 384 sono stati gli Internati militari sfruttati come lavoratori schiavi.
A cura di
Carla Antonini, Mario Miti, Elisabetta Paraboschi
Istituto di storia contemporanea di Piacenza